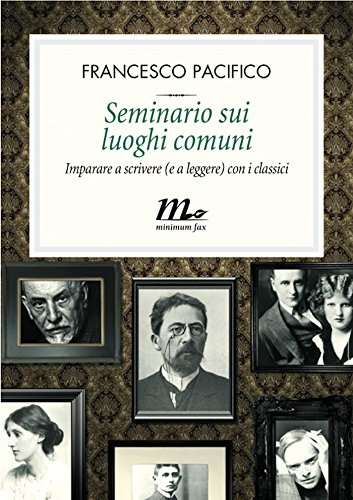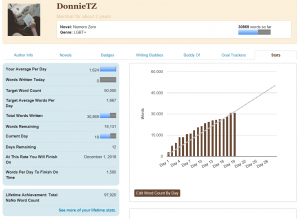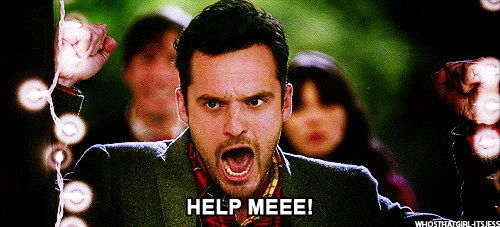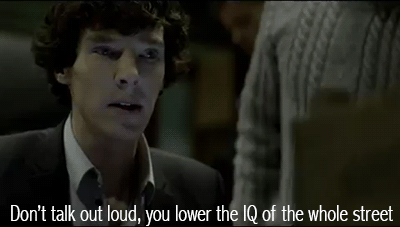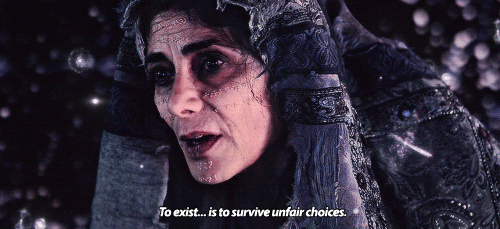Ebbene sì, ritornano gli AppuntaVenti – discussioni e appunti di scrittura, il venti di ogni mese – per parlare dei meccanismi più o meno nascosti dietro alle storie che scriviamo.
In questo articolo ho provato a dissezionare il processo che solitamente mi porta da una singola immagine o scena a un’idea decisamente più approfondita per una storia.
Come ogni razionalizzazione di un processo che va per lo più a istinto (un istinto allenato da anni, certo, ma pur sempre tale), non è legge, non tratta di verità assolute e dogmi incrollabili. Né i suoi vari punti sono in ordine cronologico. Ogni persona che scrive è a sé, ha le sue specifiche esigenze e i suoi rituali. Si tratta più che altro di un’analisi del mio procedimento di brainstorming.
Lo scopo finale sarebbe, come da titolo, allenare l’immaginazione, arma principale nelle mani di chiunque voglia scrivere!
L’immagine
Quasi tutte le mie storie e quelle di moltə colleghə con cui ho la fortuna di parlare nascono da un piccolo dettaglio. A volte quest’idea è un concetto, una dinamica, un trope, ma molte altre è un’immagine. Un singolo fotogramma che ci arriva alla mente mentre stiamo andando al lavoro, pulendo casa, portando fuori il cane. O nel momento in cui chiudiamo gli occhi per dormire e abbiamo bisogno di una storia della buonanotte inventata da noi.
Tutte queste più-o-meno-tediose attività quotidiane sono perfette per sognare a occhi aperti e allenare l’immaginazione. È importante però che le idee che il nostro cervello mette insieme non restino chiuse nella nostra testa. Il consiglio è quindi quello di appuntarsi sempre l’immagine. Bastano poche parole salvate sui nostri onnipresenti telefoni o su uno degli innumerevoli quaderni che noi scribacchinə siamo solitə collezionare. Non deve avere troppo senso, non dev’essere già una trama, non ha bisogno di specifiche: si scrive quello che si vede al solo scopo di non perderlo via fra la lista della spesa e l’appuntamento dal dentista.
Ora, per me le storie partono dai personaggi. Però mi rendo conto che non tutte queste singole genesi arrivano alla mente già popolate. Quindi un ottimo primo passo potrebbe essere quello di abitarle con una coscienza. Dico così perché potrebbe essere una persona, sì, ma anche un fantasma nella piccola finestra del nostro castello gotico, un animale nel mezzo della nostra foresta, un mostro in una palude, qualsiasi cosa di senziente che possa avere una vita da personaggio.
Per la versione definitiva de “Il corpo che indosso” (dopo la sua genesi come giallo di cui non parleremo più, promesso) una delle prime immagini era quella di due adolescenti che parlavano su un balcone di notte, la luce calda che arrivava dalla posrta-finestra alle loro spalle. Tutto qui.
I dettagli
Non resta che dissezionare l’immagine, esplorandone ogni minimo dettaglio.
Per farlo basta continuare a porsi domande sull’immagine: chi sono le persone che la abitano? che emozione trasmette? come ne descriverei l’atmosfera? che colori posso vedere o che suoni posso sentire? che odori, che temperatura? che luogo è? che ragione hanno queste persone per trovarsi lì? cosa sta succedendo?
Lo so che suona molto banale, ma la natura di questo procedimento non è niente di fantascientifico: più si scava, più la nostra immaginazione se ne verrà fuori con altre idee, con collegamenti e motivazioni.
Di solito io non mi metto ad appuntare ogni singola parte di questo procedimento, perché questa fase è malleabile e fumosa, sempre soggetta ad aggiustamenti istintivi, ma le mappe mentali e le liste sono sempre uno strumento utile se sognare a occhi aperti non basta!
Per il mio libro, sapevo già che le due persone nell’immagine erano Gio ed Elia (al tempo con altri nomi), due personaggi di un’altra storia (sì, il giallo) che mi stavano tormentato per avere un romanzo tutto loro. Non erano gli adulti di quella prima versione, però, ma due adolescenti, quindi in un punto totalmente diverso delle loro vite. La luce alle loro spalle era “casa”, un luogo sicuro, ma loro erano fuori, nell’aria fresca della notte, immersi in un’atmosfera calma ma in qualche modo malinconica.
Due dettagli hanno poi fatto da base per scene future: i capelli di Elia e la sigaretta di Gio.
Le persone
Come ho scritto all’inizio, però, le mie storie nascono dai personaggi. E quindi gran parte della mia immaginazione finisce per concentrarsi su questo. Dall’immagine, infatti, si può intuire già molto di quello che finirà per caratterizzare le persone al centro delle nostre storie. Sappiamo vagamente come appaiono e chi sono perché abbiamo scavato nell’immagine, ma per dare loro spessore dobbiamo capire cosa vogliono, di cosa hanno bisogno, che ostacolo interiore dovranno affrontare, che “fatal flaw” hanno, eccetera.
Insomma, è il momento in cui gli strumenti della narratologia possono venire in nostro soccorso, sia che siano applicati istintivamente che razionalmente, in base alle nostre predisposizioni. Può essere un procedimento estremamente strutturato, con schede personaggio e simili, oppure un’esplorazione tutta interna in cui li conosceremo sempre meglio più indirizzeremo l’immaginazione a costruirli (QUI parlo più nello specifico di alcune idee per caratterizzare i personaggi).
È anche il momento di capire in che punto del loro arco si colloca la nostra immagine: sono all’inizio del loro cammino, sono nel momento più buio della loro storia, sono alla fine quando il cambiamento (salvo casi speciali) è già avvenuto?
Per “Il corpo che indosso” sono arrivata alla conclusione che quel momento sul balcone fosse un momento di transizione per entrambi i personaggi. Elia con le sue fragilità (sommate a quelle tipiche dell’adolescenza) che finalmente trova in sé un po’ di assertività, Gio con la sua paura dell’abbandono e la sua protettività verso Elia, costretto a mettere tutto da parte e ascoltarlo.
Mi sono chiesta da dove arrivassero, questi due, cosa li avesse resi chi erano, e dove potevano finire. Così sono nati tanti altri personaggi, come le loro famiglie e i loro amici. Così sono nate la nonna di Gio, Libera, e la sorella di Elia, Eleonora.
Il mondo
Per me questo è uno degli ultimi punti quando parto dalla mia immagine per arrivare a una storia, per altre persone probabilmente il primo, sta di fatto che i personaggi non aleggiano nel vuoto. La nostra immagine, come abbiamo già esplorato grazie all’analisi dei suoi dettagli, ci restituisce un’ambientazione.
Può essere fantastica o realistica, può essere un singolo luogo specifico in cui i nostri personaggi si troveranno o un intero mondo di cui stiamo vedendo uno scorcio. Ma, anche qui, continuare a esplorare l’immagine con la nostra mente può farci accumulare informazioni sull’ambientazione della nostra storia, ottimo punto di partenza sia che il nostro mondo sia enorme e necessiti di successiva costruzione e ricerca (penso al fantasy o alla fantascienza), sia che si tratti del mondo che viviamo e abitiamo tutti i giorni.
A volte, sono proprio i piccoli dettagli a rendere realistico un universo, e di dettagli da esplorare potrebbero essercene a decine nella nostra immagine di partenza. Avremo così idea di atmosfera, colori, architettura, arredamenti, flora, fauna, ecc.
“Il corpo che indosso” ha un’ambientazione molto, molto specifica. La finestra da cui esce la luce calda della mia immagine aveva qualcosa di rassicurante: “casa”, come ho detto. Mi sono chiesta di chi fosse, quanta importanza avesse per i personaggi, come fosse dentro, cosa rappresentasse, quali cambiamenti la aspettassero. È così che è nato l’Appartamento di Libera, il luogo dove si svolge l’interezza della storia di Elia e Gio, con tutta la sua simbologia emotiva.
Il conflitto e il cambiamento
Ma se i personaggi e il mondo sono punti fondamentali, le storie sono niente senza conflitti e cambiamenti.
La nostra immagine può ancora esserci utile, in questo senso: possiamo cercare il conflitto fra le persone che la popolano, o fra le persone e il loro mondo, fra elementi diversi dell’ambientazione che possiamo scorgere o grazie a dettagli in cui è possibile trovare della tensione. Possiamo, insomma, scavare sempre più a fondo, domanda dopo domanda, alla ricerca di un conflitto o di un potenziale cambiamento.
Lo scopo finale è, come sempre, riuscire ad andare da quest’idea a una storia.
C’è chi a questo punto è prontissimo a buttare giù le prime pagine (forse perfino prima) e chi ha bisogno di usare una struttura per “plottare” l’intera storia, chi scoprirà man mano gli eventi e chi è pronto ad appuntare ogni snodo fondamentale. L’importante è ricordarsi che ai nostri cervelli piace il cambiamento, che è il motivo per cui si insiste spesso sulla necessità di un’incidente scatenante che cambi la situazione di partenza della storia, di ostacoli che la rendano interessante e di punti di tensione che tengano il lettore immerso nelle vicende.
Anche qui, si tratta di capire più o meno quale metodo sia il più adatto alle nostre inclinazioni (un video che adoro è questo di Ellen Brock, perché credo abbia trovato una buona categorizzazione su cui è possibile costruire un metodo adatto a noi).
Io amo immaginare i conflitti fra personaggi. Sapevo già che la relazione fra i due della mia immagine aveva alcuni tratti della co-dipendenza, sapevo che erano cresciuti insieme, sapevo che le due personalità così diverse che stavo iniziando a esplorare erano destinate a non capirsi fino in fondo. Eppure, in qualche modo, sapevo anche che erano perfetti per stare insieme… poteva trattarsi solo della necessità di crescere, maturare, trovare un proprio equilibrio.
Per concludere…
Spero che questo articoletto possa essere lo spunto per fare un esercizio mentale a partire da un’immagine trovata su Pinterest, o venga usato per affinare una storia su cui magari siete bloccatə ripartendo dalla sua idea iniziale o che vi dia semplicemente una spintarella a pensare meglio un’idea con cui state giocando da un po’ nella vostra testa.
È stato interessante per me vivisezionare questo procedimento e vedere come a volte può funzionare la mia immaginazione.
E ora… buona scrittura!